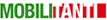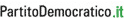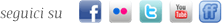Domenica sera, mentre il ministro Speranza parlava in televisione da Fazio, io seguivo l’hashtag #CTCF. Di tutti gli utenti che twittavano mentre seguivano la trasmissione, neanche uno (NON-UNO) che io ricordi ha capito che il ministro stesse istigando gli italiani alla delazione. Nessuno ha evocato la Stasi né l’Ovra, nessuno è andato a dormire scandalizzato. Nessuna polemica, zero. La mattina dopo, Speranza era trending topic su twitter, l’hashtag semiserio #cinesegnalazione era il primo, i meme col ministro in divisa da SS, le vignette coi vigili e i vicini spioni circolavano all’impazzata ed è stato così per tutto il giorno. Stamani, tutti i giornali di destra avevano l’editoriale sul ministro che vuole farci spiare dai vicini, naturalmente perché è “comunista”. Perché vi racconto questa cosa? Per dire che al di là di una frase più o meno infelice che può capitare a tutti* questa roba non avviene per caso, è costruita. C’è gente che ci lavora sopra. E altra gente che abbocca. Aspettate.
Sempre ieri, il giorno in cui il web italiano si è occupato della fondamentale questione dell’incitazione di Speranza alla delazione per far rispettare una norma, il divieto di feste private che – attenzione – alla fine nel decreto non c’è neanche se non come raccomandazione, circolava nelle chat e, sempre, sui social, un finto Dpcm contenente norme assurde. Però non troppo assurde, come ha spiegato accuratamente Fanpage.it. Assurde abbastanza per attirare critiche e ironie sul governo sui social e nelle chat o per terrorizzare o far incazzare la gente, ma scritte in modo verosimile e accurato, con tanto di riferimenti normativi e numero (ovviamente falso) di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e accompagnate da altre già circolanti o plausibili, in modo da essere credute. Niente che qualsiasi professionista della comunicazione o della legislazione non potesse battezzare come falso grazie a una semplice occhiata in più intendiamoci, eppure molti professionisti hanno rilanciato e commentato il finto Dpcm con ironia o indignazione, perché sui social quell’occhiata in più difficilmente si dà. Un lavoro ben fatto insomma. Che richiede tempo, e qualcuno che ci lavori sopra. E qualcuno che abbocchi, appunto.
Da notare che per tutto il precedente pomeriggio ci eravamo deliziati con la differenza tra attività sportiva e attività motoria, e su quale delle due attività preveda l’obbligatorietà della mascherina, ma è durato poco perché, mannaggia, è intervenuta tempestivamente una circolare del Viminale a chiarire. Nei giorni precedenti ci si era molto baloccati sull’obbligatorietà della mascherina all’aperto anche in caso di isolamento totale (“e se cammino da solo in una strada deserta?” “ma allora non importa dai” “e se il vigile mi fa la multa?” “ma se c’è un vigile non è deserta!”, e così via).
Perché vi racconto queste cose? Perché qualcuno, e mi spiace, se l’è presa se in questi giorni ho giocato un po’ con l’hashtag #regazzini e ho sfottuto certe critiche al governo parlando di giornate di puntacazzismo, parola al cui significato potete risalire agevolmente anche se a prima vista esso potrebbe non sovvenirvi.
Ora. Io difendo questo governo per convinzione. Soprattutto difendo un ministro della Sanità di cui mi fido ciecamente (anche se non ci parlo da gennaio). Tuttavia non penso affatto che il governo o il ministro siano infallibili. Esistono le fughe di notizie, esistono le frasi infelici, esistono le cose che si potevano fare meglio o fare prima, esiste perfino che possa esserci una divergenza tra un ministro e l’altro o tra un ministro (nun ce provate, ripeto: non ci parlo da gennaio!) e il presidente del consiglio su come scrivere una norma. Quindi, facciamo così: hanno ragione i puntacazzisti su tutto, libero puntacazzismo in libero stato. Tuttavia voglio dire lo stesso due cose.
La prima. Imporre restrizioni alla vita delle persone è molto antipatico; un governo dovrebbe raggiungere i suoi obiettivi, fra cui quello di tutelare la salute delle persone, in altri modi. In questo caso specifico, che si chiama pandemia del Covid 19, si dà il caso però che un altro modo non c’è. La circolazione del virus non dipende dal numero di terapie intensive disponibili, dal Mes, dai vaccini anti influenzali. Tu puoi avere tutti i ventilatori che servono, distribuire tutte le mascherine del mondo, ma se la gente si ammassa, si ammala. E la cura non c’è, e le cure che ci sono a volte e per qualcuno non bastano. Raccomandare o imporre comportamenti che limitano la vita sociale delle persone non significa quindi voler punire i cittadini o scaricare su loro la “colpa” per qualcosa che il governo doveva fare e non ha fatto o non ha fatto bene. È una cosa necessaria e non è colpa di nessuno, a parte il maledetto virus. Anche la Merkel fa i lockdown. Anche chiunque. Ci sono attività, come andare al lavoro o andare a scuola, alle quali possiamo rinunciare solo in casi estremi, e ci sono attività che sono piacevoli ma delle quali per un po’ dovremo fare a meno. E certe cose non servirebbe neanche scriverle nelle leggi, se le pensassimo da soli.
E qui arrivo alla seconda cosa, che è più importante. A me, vedete, piace essere trattata da persona adulta. Non mi piace essere presa in giro da sconosciuti che confezionano simpatiche campagne social o fake news per le chat. E le cose mi piace capirle da sola. Anche se il governo a volte pasticcia un po’ quando scrive norme che nessun amministratore avrebbe immaginato mai di dover scrivere, io sono felicissima che la legge non specifichi troppo qual è la casistica precisa che devo rispettare per considerare una strada assolutamente deserta e togliermi legittimamente la mascherina. Non penso che il governo faccia queste norme per farmi prendere una multa, e non penso a come fregare il governo senza prenderla. Non penso a organizzare una festa di nascosto dai miei vicini perché è vietato (non è vietato!) e-però-magari-loro-mi-fanno-la-spia, penso che effettivamente, se me lo dice anche il governo con tutto il Cts e il cucuzzaro, non è il caso di organizzare una festa. Non voglio però che il governo mi dica quante persone posso invitare a casa mia, perché magari capita il giorno che scoppia un acquazzone, ci inzuppiamo e devo dire proprio alle mie due amiche di salire un attimo ad asciugarsi anche se non ho la metratura (è un esempio ok? non ho mai avuto molta fantasia!). Non si tratta di questo. Non è questione di come non prendere la multa.
Si tratta di affrontare una sfida inedita e di farlo come comunità, e come persone adulte. Per questo me la prendo con chi ha il problema del calcetto. Mica perché non lo so che oltre che quello del calcetto avete problemi ben più seri, i ragazzi a scuola, l’attività da mandare avanti, il tampone da fare che c’è la fila, il vaccino per la nonna che non si trova. Ma perché penso che questa situazione meriti di essere affrontata con un altro tono. Perché è una tragedia, non un gioco di società. Un fatto mondiale non la sfida di Conte e Speranza.
Che poi penso alle nostre bolle social nel dire questo, mica alla gente là fuori che lo sa benissimo. A noi giornalisti, noi più o meno addetti ai lavori, noi piccolissimi influencer. Perfino un leader di partito domenica ha fatto il tweet polemico sulla mascherina mentre si corre. Invece di fare una telefonata a un numero che ha sicuramente in rubrica, capire meglio e poi dare una mano a tranquillizzare la gente. Perché non è un gioco di società, e nemmeno un giochetto politico. Siamo dentro una sfida che sarà ancora lunga e difficilissima, ma potremmo giocarcela in un clima molto diverso da questo. Ed è una cosa che dipende da ciascuno di noi.
* Ecco però (presa dalla bacheca facebook del mio amico Giorgio Piccarreta, grazie) la trascrizione letterale della domanda di Fazio e della risposta di Speranza per capire che il senso era comunque piuttosto chiaro e no, non si evocava lo stato di polizia, ma si ripetevano concetti usati piuttosto di frequente da questo ministro:
Domanda di Fazio:
“Ma come si fa a vietare una festa? Chi è che va a controllare e a bussare alle porte degli appartamenti per vedere se c’è una festa?”
Risposta di Speranza:
“Intanto, quando c’è una norma, va rispettata. In questi mesi gli italiani hanno dimostrato di non avere bisogno di un carabiniere o un poliziotto a controllarli personalmente. Ma è chiaro che aumenteremo anche i controlli, ci saranno segnalazioni. Io mi fido molto anche dei genitori del nostro Paese. Nel momento in cui si dà un’indicazione di natura formale in un Dpcm e si pone un divieto, io sono convinto che la stragrande maggioranza delle persone seguirà l’indicazione che è stata data.”