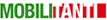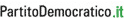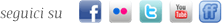Pubblicato su The post internazionale
Il dibattito nella direzione Pd, con alcune pregevoli eccezioni, ha dimostrato che dopo il dramma dei primi giorni post voto il partito sta perdendo di vista la dimensione della sua sconfitta e del suo problema. Le ironie della batteria social renziana sulla percentuale del risultato del Pd di Letta, in fondo simile a quello di Renzi, sono totalmente fuori luogo: l’affondamento del partito della sinistra di governo nasce dallo smarrimento della sua identità e delle sue ragioni che toccò il suo culmine negli anni del Giglio magico, e continua oggi. Tuttavia non è affatto vero che quel risultato sia “non catastrofico” come lo ha definito ieri il segretario. Così come è grottesco il giudizio che dopo la costernazione dei primi giorni sta emergendo a sinistra sul risultato dei 5 Stelle, che in fondo “hanno perso punti rispetto al 2018” e “sono tornati alle percentuali dei tempi del Conte 2”, per cui in fondo in fondo avrebbero perso le elezioni anche loro.
Vincere o perdere infatti è questione di obiettivi. Il Movimento 5 Stelle aveva l’obiettivo di dimostrare di essere ancora vivo, e l’ha centrato. Il Pd aveva l’obiettivo di contendere alla destra il governo del paese, e l’ha mancato. In questo senso, la separazione di luglio, al di là delle rotture anche personali, è stata molto più consensuale di quanto Letta e Conte abbiano confessato anche a se stessi. Entrambi hanno fatto, come è normale e legittimo, una valutazione strategica: Conte ha valutato che la sopravvivenza dei 5 Stelle si ottenesse con un ritorno all’identità e con una corsa solitaria centrata sulla sua personale popolarità. Letta ha valutato che la strada giusta per il Pd fosse rivendicare il sostegno a Draghi e l’affidabilità del “primo partito”. Entrambi hanno, come è stato detto, “proporzionalizzato” il Rosatellum, decidendo di non puntare sulla coalizione e rinunciando così a una vittoria possibile in buona parte dei collegi. Una catastrofe, se volete una catastrofe con due colpevoli, dal punto di vista di chi si augurava che la vittoria non andasse alla destra. Ma con questa strategia uno dei due leader ha raggiunto il suo obiettivo, l’altro lo ha mancato in pieno.
E non si dica, come si dice e si è detto anche ieri, che c’è chi ha pensato al paese e chi a se stesso: tutti i partiti, quando arrivano alle elezioni, pensano al paese e a loro stessi. Ogni partito pensa che bene del paese sia la propria sopravvivenza e il proprio successo, altrimenti non sarebbe tale. Fare la morale agli altri perché si sono permessi di avere una strategia migliore della tua è indice di un’arroganza falsamente consolatoria e fin troppo nota.
Ma c’è un’altra ragione per cui il risultato del Pd è tutt’altro che “non catastrofico”: a causa del successo della strategia di Conte e dell’affermazione, per quanto inferiore alle loro attese, del “Non-Terzo” polo calendiano, il Pd per la prima volta si trova a non essere più circondato dai sette nani, ma ad avere competitor realmente consistenti e insidiosi sia a destra che a sinistra. È una situazione pericolosa, che senza una reazione può innescare, come è stato detto, un fenomeno “francese”, e cioè quello che è il prosciugamento (ai limiti dell’azzeramento) dei consensi del Partito socialista. Un processo che, attenzione, può essere molto veloce. Guardare all’estero può servire: anche il Psoe spagnolo si è trovato in una situazione simile, stretto tra Ciudadanos e Podemos. Pedro Sanchez ha scelto l’alleanza con Podemos, e governa la Spagna. In Francia, invece, il presidente è Macron. Lo ha detto ieri Andrea Orlando: ci schiacciamo fino a perdere noi stessi su qualunque formula di governo o leadership esterna perché non abbiamo scelto la nostra identità, il nostro punto di vista sul grande tema sociale (salvo poi non riuscire nemmeno a rivendicare i risultati perché siamo già schiacciati su un’altra cosa, come ha aggiunto Peppe Provenzano). Ma il Pd è in grado di scegliere? Come? Quanto risentimento, quanta chiusura retorica sulle critiche alle primarie, quando la domanda da farsi sarebbe una sola: funzionano?
Infine c’è un tema di credibilità, messo in evidenza ma forse non abbastanza spiegato dal giovane neo deputato napoletano Marco Sarracino. Un tema perfino stucchevole, e però qui mi viene un esempio. Uno dei messaggi forti di ieri è stato: mai più governi tecnici e istituzionali, se cade il governo si va al voto. Benissimo, anche qui non tanto per moralismo quanto perché in questa legislatura “governo tecnico” vorrebbe dire per il Pd fare maggioranza con Fratelli d’Italia, mica coi 5 Stelle, e forse (speriamo) sarebbe un po’ più complicato. Tuttavia come fai a lanciare questo messaggio con un segretario che è stato premier di un governo di larghe intese e che ha fatto tutta la campagna elettorale maledicendo chi aveva interrotto l’esperienza di un governo “senza formula politica”? Le parole hanno ancora un peso? E sorvolo sulle critiche feroci sentite ieri alla legge elettorale in vigore e anche a chi “non ha voluto cambiarla”, tutte fatte da gente che quella legge l’aveva scritta e votata, anche con una discreta forzatura parlamentare: basta dire che Rosato non è più nel Pd per scagliarsi liberamente contro il Rosatellum? E sono tutti argomenti sentiti in campagna elettorale. È dubbio che fossero (e siano) argomenti efficaci.
Detto questo il Pd farà una grande chiamata, e sarà giusto ascoltarla e partecipare. Non c’è altra salvezza per la sinistra, è doveroso provarci. Anche qui però, e sarebbe bello che venisse detto con l’equilibrio, il buonsenso e la soavità con cui lo ha detto ieri il sindaco di Bologna Matteo Lepore: sia una chiamata e un’apertura vera, interessata all’ascolto e al cambiamento, che metta in gioco qualcosa. Perché ieri in certi momenti sentendo quella sfilza di scatti d’orgoglio, critiche agli assenti, condanne a chi se n’è andato (in qualunque direzione e per qualsiasi motivo, evidentemente tutti uguali), no a suggerimenti, sentiti ringraziamenti, difesa di ogni scelta, accuse agli avversari e anche ai possibili alleati, la domanda sorgeva spontanea: ma a chi vi volete aprire?