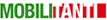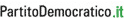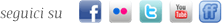(questo post è uscito su Huffington post)
Sentir parlare tanto di disciplina di gruppo, di espulsioni minacciate (o autominacciate), di libertà di coscienza, mi ha fatto tornare in mente una cosa. Perché i voti in dissenso, certo, ci sono sempre stati, dacché i parlamenti esistono. Solo che, ecco, nella prima repubblica votare contro aveva un prezzo. Non necessariamente l’espulsione, ma un prezzo. Non ci facevi carriera, su un voto in dissenso, semmai il contrario. E a nessuno sarebbe venuto in mente di rivendicare il suo diritto al dissenso dicendo “non siamo mica una caserma”. Che poi vorrei sapere a quale persona “normale”, guardando il Pd, viene in mente una caserma. Semmai, come ha detto Epifani, una caserma dove qualcuno sta sempre in divisa e qualcun altro sempre in libera uscita, e questa cosa non è accettabile. Uno può ribellarsi per carità, ma non può avere la ribellione come linea politica. Altrimenti vuol dire che ha sbagliato qualcosa, secondo me.
Insomma, mi è venuto in mente che bisognerebbe farselo raccontare, cosa voleva dire votare in dissenso. Come si faceva, perfino. E siccome io ci ho fatto un libro, a farmi raccontare le cose da chi le ha vissute, mi è tornato in mente che io quel racconto ce l’ho. Tanto per stare tranquilli, e perché a nessuno venga in mente Stalin o il centralismo democratico, la domanda sul voto in dissenso non l’avevo fatta a un vecchio comunista avvezzo all’obbedienza alla “Ditta”. Fu a Domenico Rosati, già senatore democristiano (oltre che già molte altre cose bellissime e importanti) che feci la domanda su quella volta che aveva votato contro la prima guerra del Golfo, in dissenso dal suo gruppo. E gli chiesi di come era arrivato a quella decisione di coscienza, da pacifista cattolico intransigente. La domanda era sbagliata. Infatti mi rispose così: (continua qui)